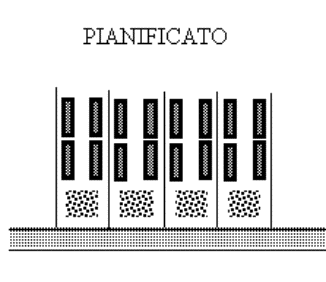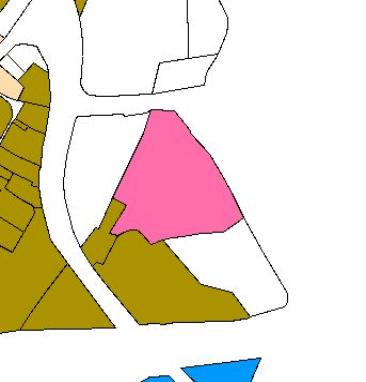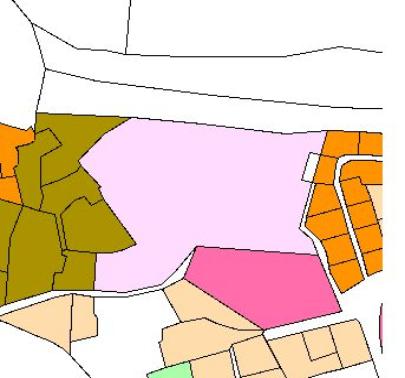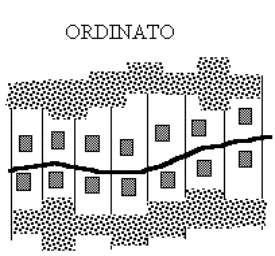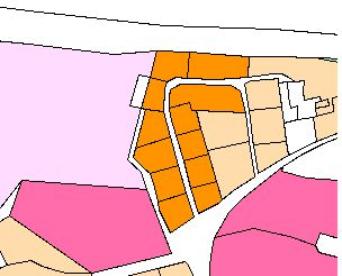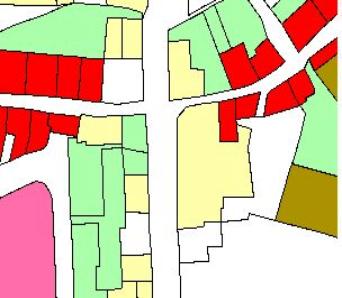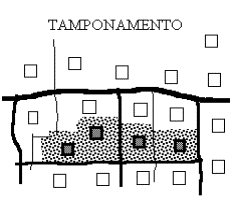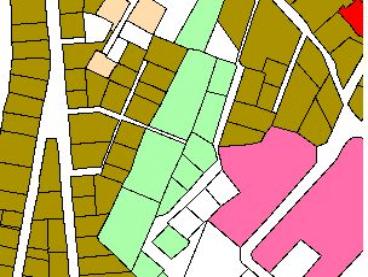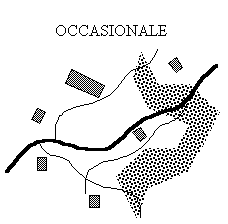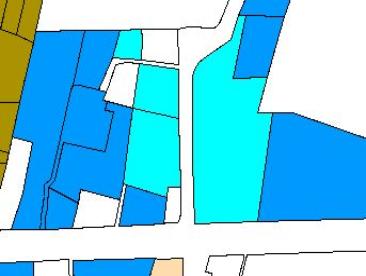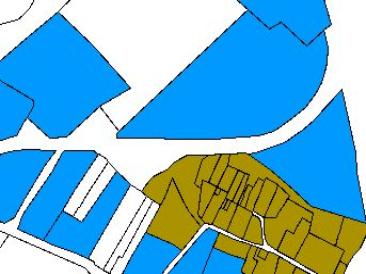MORFOTIPOLOGIA
EDILIZIA
Nell’analisi della tipologia edilizia, la necessità di
conseguire dati omogeneamente determinati in tempi relativamente brevi ha
imposto una modalità di procedimento speditiva, che ha considerato le sole
caratteristiche morfologiche rilevabili —o intuibili— dagli spazi liberamente
accessibili o dalla cartografia aerofotogrammetrica: un rigoroso studio tipologico avrebbe infatti
comportato, quanto meno, il rilievo planimetrico dei piani terra di tutti gli
edifici ad una scala utile a descrivere strutture portanti, conformazione ed
aggregazione degli spazi interni, impianto distributivo dell'organismo architettonico.
Per questo motivo, pur utilizzando la definizione "tipologia
architettonica", si ritiene più corretta l'accezione di lettura
"morfo-tipologica", sviluppata sul territorio urbano. Gli elementi
morfologici presi in considerazione per la determinazione delle classi
tipologiche sono: - modalità di edificazione del lotto; rapporti tra edificato, aree scoperte e percorsi; - modalità di aggregazione e distribuzione degli spazi
interni, dedotte attraverso la lettura dei prospetti architettonici; - modalità di aggregazione in tessuti edilizi del
sistema edificio-area di pertinenza con quelli adiacenti. Tali modalità insediative, riscontrabili in forma
consolidata nel nucleo urbano centrale, non presentano caratteri di
regolarità tipologica nell'organizzazione urbana periferica, dove si
riscontrano frequenti eccezioni e alterazioni nel rapporto edificio - lotto
ed edificio - strada oltre ad eterogeneità di linguaggio architettonico.
Questa riduzione della tipicità dei manufatti edilizi della periferia è da
ascriversi alla rarefazione dei rapporti gerarchici e di continuità
insediativa, caratterizzanti il "centro storico", nella formazione
dei tessuti, nonché ad un crescente grado di eterogeneità e marginalità delle
funzioni insediate (commistione di attività produttive e residenza, ecc.) |
ANTE
1940
|
||
|
CORTE |
Sono gli edifici di originaria matrice rurale ancora
ricono-scibili all’interno del tessuto urbano. Il rapporto con il per-corso
non è mai diretto, ma mediato attraverso l’area sco-perta, principale sede
delle attività agricole lavorative. L’organismo edilizio è costituito da un
edificio principale ad uno o due piani a corpo semplice di forma rettangolare
e profondità monocellulare a fronte cieco sul confine, mentre gli affacci si
aprono sullo spazio interno. La tras-formazione di questi edifici in
organismi edilizi residen-ziali ha prodotto notevoli modificazioni del tipo
originario (quali l’apertura di affacci diretti su spazi esterni o
l’acquisizione di servitù di veduta sulle corti contigue) facendone perdere
l’originaria caratteristica di recinto chiuso. Nelle aree periferiche la
variazione pre-valente del tipo si riscontra sotto forma di trasformazione in
edifici mono-bifamiliari assimilabili alla tipologia moderna a villino, con
alterazione del rapporto originario edificio-lotto e modifiche distributive e
volumetriche |
|
|
|
SCHIERA |
Questa categoria contiene gli edifici a fronte
monocellulare (4-6 m.) e due soli affacci, uno diretto su strada e l'altro su
uno spazio scoperto retrostante di pertinenza, in uso esclusivo della casa; i
muri laterali —ciechi— individuano il confine con gli edifici adiacenti e
costituiscono appoggio comune per gli orizzontamenti. Caratteristica propria
del tipo è la coincidenza con un’unica unità abitativa, organizzata su più
livelli: il piano terra assolve a funzioni mercantili e di piccolo
artigianato e gravita direttamente sul percorso; i piani superiori sono
destinati ai locali di abitazione, a cui si accede da una scala interna. Una
volta raggiunta l'altezza limite —tipica da luogo a luogo— i successivi
processi di accrescimento della casa a schiera avvengono per intasamento
dell'area di pertinenza, spesso ridotta a chiostrina interna. |
|
|
|
PSEUDOSCHIERA |
Questa
categoria contiene gli edifici tipologicamente assimilabili alla casa a
schiera, ma con elementi di alterazione rispetto alle caratteristiche
architettoniche o d’uso, precedentemente descritte. In particolare ciò può
verificarsi sotto forma di variazione dimensionale in profondità ed altezza
dell'edificio e aumento del numero di unità abitative. |
|
|
|
|
ANTE 1940
|
POST 1940
|
|
|||
|
PSEUDOLINEA |
Questa
categoria contiene gli edifici appartenenti alla stessa matrice della casa in
linea, ma con elementi di alterazione rispetto alle caratteristiche
architettoniche o d’uso, successivamente descritte —ad esempio: un corpo
scala in posizione decentrata, che distribuisce un solo appartamento per
piano—. Analogamente alla tipologia di pseudoschiera, a questa categorie sono
ascrivibili anche i manufatti edilizi ad essa assimilabili per caratteri
distributivi ed architettonici ma con una modalità insediativa caratteristica
ad esempio del tipo a villino. |
|
|
|
||
|
LINEA |
Questa
categoria contiene edifici di profondità bicellulare (corpo doppio)
caratterizzati da un corpo scala, in posizione baricentrica, che distribuisce
due o più appartamenti per piano; questi risultano costituiti da una serie di
cellule disposte "in linea". La profondità a corpo doppio indica la
normale attitudine del tipo ad affacciarsi sui lati lunghi e ad aggregarsi
sui due fianchi ciechi. L’edificio
si colloca generalmente in rapporto diretto con la via o la piazza sulla quale attesta il prospetto pubblico
specializzando il piano terra ad uso commerciale; il retro affaccia su uno
spazio privato di pertinenza. I fianchi sono normalmente privi di affaccio;
qualora non risultino aggregati, possono eventualmente presentare finestre di
vani di servizio, ad esempio bagni sulla testata dei corridoi centrali. |
|
|
Nelle
aree periferiche il tipo, che nel centro storico costituisce un fronte
edilizio continuo su percorso, può presentarsi in forma isolata o in
posizione arretrata all'interno dello spazio di pertinenza a costituire un
rapporto tra edificio - lotto - percorso assimilabile alle modalità insediative
delle moderne tipologie a palazzina e a villino. |
||
|
BLOCCO CHIUSO |
In
questa categoria sono stati raggruppati i fabbricati che presentano
profondità del corpo edilizio di tre o più cellule; normalmente, questi si
sviluppano attorno ad un vano centrale —coperto ed illuminato dall'alto— in
cui è situata la scala condominiale; negli organismi più articolati lo spazio
centrale si trasforma in una o più chiostrine con lo scopo di dare aria e luce ai vani interni. Il rapporto
col percorso è sempre diretto, almeno per quanto riguarda il lato di accesso.
Questa tipologia edilizia può essere aggregata ad edifici adiacenti per uno dei suoi lati; ovvero tramite un
corpo basso di collegamento —a destinazione per lo più commerciale od
artigianale— che ricostituisce la continuità della parete edilizia lungo il
fronte stradale, al piano terra; ovvero per l'intera altezza del fronte, ma
tramite una sola cellula in profondità sul fronte strada. |
|
|
Nella
fase post-bellica la tipologia a blocco chiuso mantiene pressoché inalterati
i caratteri morfologici, variando pressoché esclusivamente nei connotati
architettonici |
||
|
|
ANTE 1940
|
POST 1940 |
|||
|
BLOCCO APERTO |
Questa
categoria contiene quegli edifici plurialloggio "a blocco" che
presentano un'articolazione più complessa dei corpi di fabbrica, non
chiudente spazi interni a carattere privato e senza una chiara distinzione
tra facciate di rappresentanza ed affacci secondari; gli edifici, pertanto,
si sviluppano sempre con una serie di fronti indistinte, necessariamente in
numero superiore a quattro. |
|
|
A
questa tipologia sono assimilabili gli edifici plurifamiliari moderni ad alta densità abitativa
caratterizzati da una disposizione planivolumetrica sviluppantesi all'interno
del lotto di pertinenza e svincolata dalla maglia viaria, spesso
arbitrariamente rispetto alla gerarchia degli allineamenti stradali. |
|
|
PALAZZO |
Questa categoria contiene gli edifici appartenuti ad
un'unica famiglia nobiliare di cui porta generalmente il nome. La
costruzione si sviluppa con una serie di piani gerarchizzati in rapporto alle
loro funzioni di rappresentanza: al piano terra sono presenti, oltre
all'androne di ingresso che immette nella corte interna —solitamente
porticata e loggiata— ed allo scalone principale, una serie di locali di
servizio e di magazzini; al primo piano —il cosiddetto piano nobile— sono
situati i locali che rivestono funzioni sociali; ai piani superiori sono
collocati gli appartamenti privati e gli alloggi di servizio. La gerarchia
dei piani si riflette nel trattamento architettonico dei prospetti. Il palazzo occupa le posizioni divenute nodali nel
processo di sviluppo del tessuto
urbano derivando dalla rifusione di tipologie seriali preesistenti o dalla
rifusione dei loro lotti e sostituzione delle strutture architettoniche. |
|
|
|
|
|
VILLA |
La villa, in origine, è una vera a propria tenuta
agricola che possiede, nel territorio di proprietà, una serie di costruzioni
accessorie. Si presenta generalmente come vera e propria emergenza
paesaggistica in virtù della sua localizzazione, baricentrica rispetto
all'organizzazione poderale che ad essa fa capo. Nel panorama attuale di
urbanizzazione diffusa, le tenute agricole delle ville si presentano quasi
sempre frammentate in lottizzazioni a scopo edificatorio per cui,
dell'originario impian-to territoriale, non rimane che la sola parte di
stretta pertinenza dell'edificio padronale in cui l'aspetto della vegetazione
è stato trasfigurato da agricolo-produttivo a domestico-decorativo. Spesso il
lato di accesso viene differenziato dal retro: il primo si conforma in
giardino all'italiana organizzato sull'asse edificio-viale di ingresso,
assumendo un chiaro carattere di rappresentanza; sul retro viene organizzato
un giardino più rustico che diventa, in alcuni casi, un vero e proprio
boschetto di essenze mediterranee sempreverdi. |
|
|
|
|
|
|
ANTE 1940
|
POST 1940
|
|||
|
VILLINO |
In questa categoria si collocano tutti quegli edifici
monofamiliari appartenenti alla prime espansioni del suburbio, siano essi
frutto di progetti di lottizzazione o di singole localizzazioni. Il modello
di riferimento è quello della villa —quindi un tipo territoriale, ma attuato
con mezzi ben più scarsi. Il lotto di pertinenza, di limitata estensione, è generalmente
quadrangolare e dotato di recinzione; l'edificio si colloca al centro di
questo, alla minima distanza dai confini consentita dai regolamenti edilizi e
senza diretto rapporto col percorso; sul lato visibile dalla strada presenta
un piccolo giardino talvolta con essenze esotiche, mentre il resto dell'area
può essere organizzato ad orto o ad altri spazi di servizio della casa. La
forma dell'edificio è generalmente quadrata, ad un solo piano e con tetto
coperto a padiglione. Solitamente, su uno degli angoli, la facciata arretra a
formare un piccolo portico, sul quale si apre l'accesso principale. |
|
|
Nella
fase post-bellica il villino, che diventa la tipologia più caratteristica
dello sviluppo urbano periferico, mantiene costanti i caratteri morfologici
di rapporto con il lotto e con il percorso della fase prebellica, sia pure
con una sempre meno evidente ricorrenza di regole ordinative e di tessuto. Le
forme più complesse si sviluppano a due o anche a tre piani, spesso accompagnate
dalla presenza di un ulteriore nucleo familiare, generalmente parentale. Nei
casi di frazionamento proprietario viene aumentata la promiscuità delle
funzioni dell'area di pertinenza, che può sviluppare ingressi distinti e
scale esterne. Questa tipologia segna un punto di passaggio verso la
palazzina plurifamiliare vera e propria. |
|
|
PALAZZINA |
A questa categoria appartengono gli edifici
plurialloggio, originariamente situati in collocazioni periurbane, in
condizioni di indeterminatezza del tessuto edilizio. La struttura della
costruzione deriva dalla casa in linea, in quanto edificio multipiano con un
corpo scala che distribuisce due o
tre appartamenti per piano, ma il tipo di rapporto con lo spazio pubblico è
piuttosto mutuato dal villino, cioè tendente a costituire uno spazio privato
ed indipendente rispetto al contesto in cui si colloca. L'edificio occupa una
posizione centrale all'interno del lotto, spesso indifferente ad allineamenti
ed orientamenti dell'edificato circostante; l'area esterna è organizzata per
consentirne un uso promiscuo: parcheggio riservato ai soli condomini, aree
verdi collettive o pertinenziali degli appartamenti situati al piano terra
tra cui si snodano camminamenti di accesso agli alloggi dotati di ingresso
indipendente. |
|
|
Con il villino, la palazzina costituisce il tipo
edilizio più ricorrente dell’espansione periferica post-bellica. Dal punto di
vista morfologico i caratteri sono pressoché invariati, ma dal punto di vista
distributivo, planivolumetrico e architettonico, esso presenta il maggior
livello di diversificazione ed eterogeneità rispetto all’edificato del
tessuto circostante. Questo tipo di insediamento, quindi, non presenta
attitudine a costituire il tessuto edilizio tradizionale precedentemente
descritto. |
|
|
SPECIALE NODALE |
In questa categoria ricadono gli edifici a destinazione
speciale il cui organismo architettonico è composto da uno spazio centrale
unitario, nettamente prevalente rispetto ad altri vani subordinati; ad
esempio: chiese, cinema e teatri, costruzioni per manifestazioni sportive,
etc. In genere occupano una posizione polare all'interno del tessuto urbano
ed organizzano il proprio lotto di pertinenza per un uso pubblico,
integrandosi appieno nel tessuto edilizio circostante. |
|
|
Nelle aree periferiche, la caratteristica prevalente di
alterazione del tipo deriva da un rapporto spesso frammentario ed episodico
con il tessuto circostante e da un rapporto spesso irrisolto tra spazi
pubblici e spazi privati. |
|
|
|
ANTE 1940
|
POST 1940 |
|||
|
SERIALE POLARE |
|
|
Il tipo assume, nella fase post-bellica, una
articolazione volumetrica tendenzialmente più svincolata dalle geometria e
dalle morfologie urbane dei tessuti circostanti, spesso accompagnata da una
accentuazione dei caratteri spaziali di serialità e di standardizzazione
architettonica. |
|
|
|
SERIALE ANTIPOLARE |
Questa
categoria raggruppa gli edifici e recinti originariamente collocati in
ambiti allo scarto del tessuto
edilizio ovvero in posizione periferica rispetto all'aggregato urbano. La sua
forma, per quanto varia, è riconducibile alla tipologia a
"recinto", determinata in base ad una organizzazione interna del
lotto, con rapporto di tipo indiretto tra percorso ed insediamento.
L'insediamento si configura spesso come una semplice occupazione di suolo,
con carattere di intrusione all'interno di tessuti preesistenti, per i quali
assume il carattere di antipolarità. Le costruzioni, anche quando sono sistemate sul perimetro
del lotto, affacciano esclusivamente sullo spazio interno e sono costituite
da vani paritetici aggregati serialmente o da impianti spaziali aperti a
campate e senza alcuna gerarchia. Alcuni complessi ascrivibili alla fase
storica dell'industrializzazione, spesso tipologicamente contraddistinti da
un caratteristico impianto di tipo "basilicale", sono da
considerarsi vere e proprie emergenze morfologiche rispetto al contesto
urbano. |
|
|
Nel periodo post-bellico, l’accentuazione dei caratteri
di pervasività dell’espansione industriale si manifesta attraverso tipologie
in cui i caratteri di serialità e di standardizzazione diventano preminenti.
Si tratta spesso di vaste aree a destinazione produttiva o di stoccaggio
coperte solo parzialmente e successivamente intasate da tettoie od altre
costruzioni per lo più eterogenee e talvolta precarie. |
|
|
COLONICA |
In
questa categoria sono raggruppati gli edifici isolati di colonizzazione
agricola del territorio, non inquadrabili nelle case a corte, spesso inseriti
con alterazioni all'interno dei tessuti periferici contemporanei delle fasce
pedecollinari. |
|
|
|
|
|
|
TIPOLOGIA UBANA:
TESSUTI
|
|||
|
|
ANTE 1940
|
POST 1940
|
||
|
|
AREE CENTRALI
|
AREE PERIFERICHE
|
AREE CENTRALI
|
AREE PERIFERICHE
|
|
SVILUPPO EDILIZIO CHIUSO |
|
|
|
|
|
|
Centro Storico, Quartiere Umbertino, Città Ottocentesca |
Migliarina,
Scorza, Pegazzano, La Chiappa,
Mazzetta, Rebocco, Felettino, Pieve, Termo, Melara, Fossamastra, Canaletto,
Valdellora |
Nucleo Urbano Centrale |
|
|
|
Colli |
Migliarina, Ruffino, La Chiappa, Pegazzano, Buggi,
Fabiano |
Vicci |
Marola-Cadimare |
|
SVILUPPO EDILIZIO APERTO |
|
|
|
|
|
TIPOLOGIA URBANA: AMBITI |
||||
|
ASSETTO MORFOLOGICO |
ASSETTO TIPOLOGICO AMBIENTALE |
|||
|
- pianificato: codifica la presenza
di un disegno progettuale unitario in grado di specializzare uno spazio
urbano introducendo, nella maggior parte dei casi, forme e geometrie
insediative autonome rispetto al contesto: interventi di edilizia
residenziale pubblica e privata, piani di lottizzazione, piani di zona ecc. |
omogeneo |
presenza di costanti tipo-morfologiche e funzionali che
determinano una immagine ordinata dello spazio urbano, articolata per
singolarità ripetute di organismi architettonici. |
|
|
|
disomogeneo |
diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in
presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:
sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi
artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici
fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto. |
|
|
|
|
TIPOLOGIA URBANA: AMBITI |
||||
|
ASSETTO MORFOLOGICO |
ASSETTO TIPOLOGICO-AMBIENTALE |
|||
|
- ordinato: individua parti della città diffusa riconoscibili per una
modalità insediativa caratterizzata dalla organizzazione
"spontanea" (in assenza, cioè, di uno strumento urbanistico di
dettaglio unitario) di elementi in forma ripetitiva: insediamenti periferici
a villino cadenzati con regolarità di rapporto tra edificio, spazio aperto e
strada, successione di edificazione moderna aperta a costituire un fronte
stradale unitario, ecc. |
omogeneo |
Presenza di costanti tipo-morfologiche e funzionali che
determinano un'immagine ordinata dello spazio urbano, articolata per
singolarità ripetute di organismi architettonici. |
|
|
|
disomogeneo |
Diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in
presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:
sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi
artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici
fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto. |
|
|
|
|
eterogeneo |
presenza
di diversità tipologiche, architettoniche e funzionali sia interne all'ambito
che rispetto al contesto: coesistenza di edifici residenziali ed industriali
con densità eterogenee, vuoti urbani, ecc. |
|
|
|
|
TIPOLOGIA
URBANA: AMBITI |
||||
|
ASSETTO
MORFOLOGICO |
ASSETTO TIPOLOGICO AMBIENTALE |
|||
|
- di tamponamento : isola le parti edificate che non presentano affaccio
diretto sull'ambito stradale e che tendono al completamento e all'intasamento
di spazi interclusi. |
|
|
|
|
|
- occasionale: ambiti caratterizzati da casualità
insediativa, spesso con modalità
edificatorie disorganizzate e di tipo sparso: frange residenziali
marginali, aree comprese tra
insediamenti a funzioni non residenziali, vuoti urbani, ecc. |
disomogeneo |
Diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in
presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:
sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi
artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici
fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto |
|
|
|
eterogeneo |
Presenza di
diversità tipologiche, architettoniche e funzionali sia interne all'ambito
che rispetto al contesto: coesistenza di edifici residenziali ed industriali
con densità eterogenee, vuoti urbani, ecc. |
|
|
|