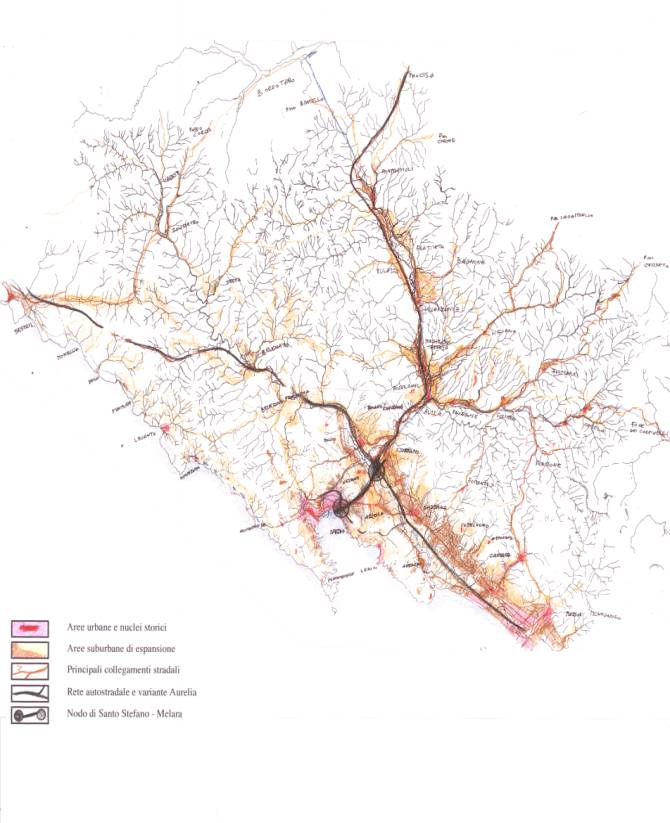2.3.
L’organismo territoriale contempora-neo
La città
della Spezia nel 1861 aveva 11.556 abitanti che progressivamente aumentarono
fino a superare le centomila unità negli anni 80. Essendo impedita la crescita
urbana verso occidente, a causa della costruzione del'Arsenale, ma anche per
l’attrazione del polo spezzino verso la valle della Magra, sede delle
comunicazioni verso il nord ed il centro Italia, il suo sviluppo fu orientato
verso la piana di Migliarina fino ad interessare tutto lo spazio delle aree
pianeggianti o pedemontane.
La figura
dell'organismo territoriale che si ottiene è tutta protesa verso lo sviluppo
delle aree pianeggianti e potenzia l'area della confluenza fra Vara e Magra in
corrispon-denza di Santo Stefano e Ceparana. Sulla pedemontana sinistra della
Magra, disposti sui terrazzi alluvionali, si distendono gli sviluppi in piano
dei centri collinari di Ortonovo, Nicola, Castelnuovo e Fosdinovo, confluenti
nelle espansioni di Sarzana e legati dal tracciato dell'Aurelia. Più a nord
Santo Stefano, con lo svincolo autostradale, l'espansione dell'autoparco e del
parco containers, si configura come area retroportuale del complesso nodo
spezzino. L'organismo della bassa valle della Magra focalizzato su Sarzana,
rafforzandosi il nodo della confluenza delle valli, tende ora a sdoppiarsi. Il
collegamento autostradale con il Levante si configura quindi come l'asse
portante degli sviluppi futuri, tanto più che oggi viene rafforzato dal terzo
lotto della variante Aurelia che, se da una parte serve per snellire il
traffico urbano, dall'altro servirà a rafforzare il collegamento con il polo di
Santo Stefano considerato il naturale retroporto della Spezia.
Le
espansioni edilizie della Spezia del dopoguerra furono regolate dal piano
Moroni del ‘62 sostituito, a partire dal 1979, dal P.R.G. vigente approvato
nell’87. Lo sviluppo contemporaneo della città tenta la ricucitura del tessuto
urbano della piana di Migliarina con alcuni interventi nell'area della
Maggiolina, ancora parzialmente libera. Il progetto (realizzato in parte), ha
interrotto la continuità di corso Nazionale e ha inserito un parco urbano
trasversale fra Mazzetta e Migliarina superando così l'area di conflitto fra le
due orditure: quella pianificata di ispirazione ottocentesca e quella
spontanea. Attuata l'occupazione delle aree pianeggian-ti, l'interesse si è
rivolto verso il territorio periurbano, immediatamente prossimo alla città. Ciò
si concretizza, a partire dalla fine degli anni '70, quando cominciano a
concludersi i lunghi iter progettuali delle aree PEEP. Si realizzano così i
quartieri di San Venerio, di Valdellora, di Pitelli, della Chiappa, del Favaro,
di Strà, di San Bartolomeo. Accanto a questi interventi sovvenzionati, piani di
zona di edilizia privata occupano, tra l'altro, le colline di Montepertico, di
Sarbia e di Melara. Accanto a questi interventi si intensifica, nelle aree di
completamento collinare, un'attività edilizia puntiforme di sensibile impatto
ambientale. Il territorio periurbano, diventato l'area di immediata espansione
della città, inizia a perdere la sua fisionomia agricola, sopratutto in
corrispondenza delle aree prossime agli insediamenti urbani, dove esso tende ad
assumere l'immagine piatta e uniforme del suburbio, accostando
indifferentemente case, terreni incolti, baracche e aree di deposito. Anche i
centri storici tendono a questo processo di banalizzazione, perdendo, di fatto,
la loro caratteristica fisionomia. Le ultime vicende assistono al potenziamento
della zona portuale con l'aggiunta di un secondo bacino a fianco di quello del
vecchio porto mercantile e la realizzazione dei banchinamenti, presso la foce
della Fossa Mastra, immediatamente collegati con lo svincolo autostradale. La
realizzazione della bretella per Lerici costituisce una valida alternativa al
viale San Bartolomeo smistandone i flussi di traffico.
|
TAV.
C.14 – SISTEMA DELL’ORGANISMO TERRITORIALE CONTEMPORANEO |
|
|