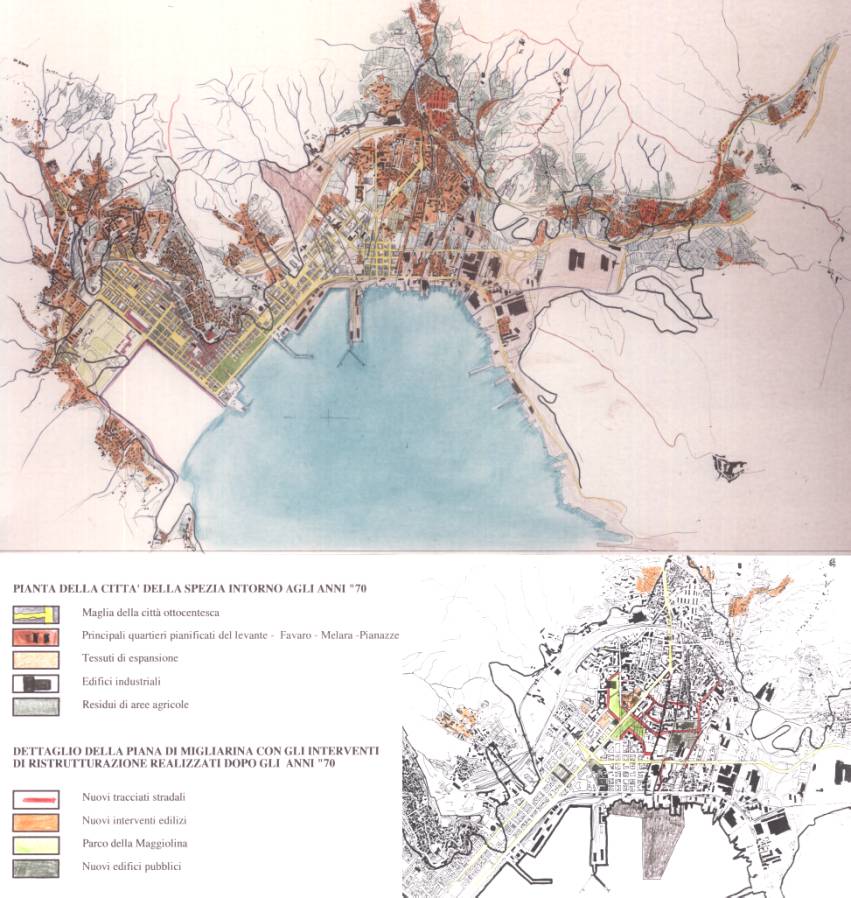2.2. I
piani del secondo dopoguerra
Il Piano
Regolatore Generale redatto da Moroni, Amati, Malatesta e Di Cagno, adottato
nel 1958 e approvato nel 1962 è il primo piano della città che sperimenta la
nuova Legge urbanistica del ’42. Si caratterizza per essere esteso a tutto il
territorio comunale e adottare lo zoning come elemento di controllo dei
processi di crescita urbana. In rapporto alle caratteristiche dei piani di
“primo ordinamento”, della prima generazione urbanistica italiana, il piano
presenta elementi di omogeneità e di diversificazione che schematicamente
possono essere così sintetizzati:
- una
previsione di espansione produttiva e residenziale largamente sovradimensionata
rispetto alle reali potenzialità di sviluppo e di crescita demografica: un
incremento del 53% delle superfici da destinare ad attività industriali,
localizzate prevalentemente nel levante urbano, e del 44% di abitanti
in-sediabili cui corrisponde un’edificabilità re-sidenziale pari a 60.000
nuovi vani a cui ne vanno aggiunti 14.500 per l’eliminazione del
sovraffollamento;
- un
complessivo sottodimensionamento delle aree per servizi pubblici (in un
contesto storico antecedente alla Legge Ponte, al D.M. 1444/’68 come anche
all’introduzione della scuola dell’obbligo) il cui standard viene quantificato
in circa 4 mq/ab, ed una loro scarsa diffusione all’interno dei tessuti urbani
in favore dei nuovi nuclei plurifunzionali e centralizzati per ciascun
quartiere
- da un
punto di vista morfologico le espansioni residenziali più consistenti sono
concentrate dal Prg nelle aree della piana di Migliarina a saturazione dei
fondovalle secondari (Fabiano, Fossitermi, Valdellora, Felettino, Limone,
Termo) con indici di edificabilità fondiari particolarmente elevati (pressoché
ovunque superiori a 3mc/mq, con punte di 11 mc/mq);
- la
presenza di alcuni “temi” rilevanti caratteristici della prima generazione
urbanistica, quali: a) un centro direzionale di
grandi
dimensioni (l’indice territoriale per esso previsto è di 50.000 mc/ha)
costituito da residenza, terziario pubblico e privato e servizi localizzato in
posizione baricentrica nella fascia urbana di cerniera tra città storica e
Piana di Migliarina compresa tra Piazza Europa, Piazza Dante e il quartiere del
Canaletto; b) un asse attrezzato “passante” che, in un’ottica ancora
pre-autostradale, avrebbe costituito una connessione territoriale alternativa a
quella di attraversamento, seguendo l’andamento del tracciato ferroviario e
congiungendo le “porte” urbane dell’Aurelia da Migliarina alla Scorza
attraverso la Galleria Spallanzani; c) la previsione del parco urbano della
Maggiolina, secondo un disegno ad “S” diretto a “frantumare” la compattezza dei
tessuti di espansione della Piana di Migliarina interrompendo l’asse di Corso
Nazionale.;
- la
tutela del paesaggio attraverso l’imposizione del vincolo paesaggistico
(L.1497/’39) cui si affianca il ruolo di marginalità delle aree agricole
collinari, “corona” indifferenziata e “bianca” attorno alle aree urbane, per le
quali l’indice previsto di 0,2 mc/mq assegna un’inequivocabile funzione di
riserva edificatoria periurbana.
Il “Piano
Moroni” si distingue, peraltro, da quelli coevi (si faccia riferimento al
disastroso P.R.G. del ’59 di Genova) per un apparato analitico rigoroso e
sistematico, in grado di costruire un’indagine compiuta sulle condizioni
economico-produttive attraverso il censimento e la classificazione delle
attività agricole e delle industrie, su quelle sociali (lettura per ceti sociali
prevalenti nelle differenti parti della città) ed abitative (sovraffollamento e
coabitazione), nonché sul patrimonio edilizio esistente attraverso il
censimento e la classificazione cronologica (edifici anteriori o posteriori al
1950) e tipologica (case isolate o adiacenti - mono o plurifamiliari). Dalle
analisi il piano procede deterministicamente, attraverso un dimensionamento
condotto con il “metodo dell’occupazione”, ad individuare un’ipotesi di
crescita che avrebbe dovuto condurre la città a raggiungere 180.000 abitanti in
trent’anni: ipotesi assolutamente disattesa e tuttavia tra le più contenute
dell’epoca. L’interpretazione strutturale e funzionale della città degli anni
‘50 viene sintetizzata da Moroni nella relazione descrittiva in tre tipologie
di tessuti urbani: vecchi insediamenti rurali e marinari, insediamenti agricoli
recenti in corso di trasformazione industriale, città vera e propria,
evidenziati nella loro apparente discontinuità ed incoerenza non senza il
ricorso alla “metafora organica” tipica dello specifico contesto
culturale : “abbiamo dunque tre parti in uno stesso corpo, non ancora
amalgamate, né dal punto di vista edilizio, e neppure dal punto di vista
sociale, (...) si tratterà di vedere quale forma urbanistica, quale carattere dovrà
assumere questo organismo, che presenta aspetti ed origini sì contrastanti, e
di vedere come questa sua forma si comporrà con la scena naturale” (P. Moroni -
P.R.G. della Spezia - 1958 -relazione descrittiva).
I
principali elementi di trasformazione del contesto comprensoriale nel corso
degli anni Sessanta e Settanta, nella fase che intercorre tra il “Piano Moroni”
e la Variante Generale a cui lavoreranno, nella prima fase di stesura, Campos
Venuti, Forno e Moroni, sono sintetizzati nel “Piano di Sviluppo Economico
della Provincia della Spezia” del 1965, e nello schema di Programma di Sviluppo
del 1977 che individuano la direttrice di crescita insediativa La Spezia-Val di
Magra come conseguenza dell’avvento dell’autostrada Genova-Livorno e della consistente
disponibilità di aree per insediamenti produttivi: il modello territoriale che
tende ad affermarsi è incentrato sul sistema portuale spezzino e connesso al
bacino della Val di Magra attraverso il sistema di scambio Porto-Autostrada-
S.Stefano in modo da “costituire una cerniera tra l’hinterland padano e
centroeuropeo e le linee di navigazione interessate ai mercati spezzini” (G.
Campos Venuti - Variante Generale al P.R.G. della Spezia -Relazione Generale).
La staticità demografica della provincia, e l’arresto della crescita del Comune
della Spezia in particolare, condizionano le prospettive di espansione, che si
indirizzano verso la Val di Magra anche in funzione dei processi di
rilocalizzazione delle attività industriali del capoluogo, verso la costituzione
di una “saldatura” comprensoriale tra funzioni portuali e funzioni produttive
del territorio, favorita dal nuovo ruolo di “polo terminale” (e non più di
passante) della città in relazione alla viabilità autostradale.
In questo
contesto, la nuova stagione “riformista” della pianificazione prende avvio con
il P.R.G. per i Servizi Pubblici del 1976, nell’ottica generale di un recupero
delle risorse economiche e fisiche del territorio (suolo urbanizzato e non,
aree di interesse ambientale) successiva ad una fase di espansione, in
alternativa al modello di sviluppo quantitativo. Il recupero delle risorse di
suolo e del patrimonio edilizio esistente prende avvio attraverso un programma
di recupero pubblicistico di aree in un tessuto urbano ”patologicamente privatizzato”,
nell’ottica del mutato quadro culturale e legislativo della riforma graduale
degli anni Sessanta e Settanta (L. 167/62, L. 765/67, D.M. 1444/68 e L.10/77).
Le
strategie prioritarie del piano, in un’ottica che pare ripercorrere gli
obiettivi delle “cinque salvaguardie” perseguite da Campos Venuti nel Piano
regolatore di Pavia, sono:
-
l’acquisizione di aree per servizi pubblici negli spazi residui all’interno del
tessuto residenziale, nella prospettiva della diffusione e del decentramento
delle funzioni civiche, della capillarizzazione degli spazi verdi e per
l’istruzione, con uno standard-obiettivo complessivo di 21,15 mq/ab.;
- la
sostanziale riduzione delle previsioni di crescita insediativa, quantificata in
circa 23000 nuove stanze, in favore di una “qualificazione della città
esistente”;
- la
pubblicizzazione di larga parte delle aree di espansione, la cui attuazione è
affidata in misura superiore al 50% a Piani di Edilizia Economica e Popolare;
- in
linea con le innovazioni introdotte dalla L.457/’78, una politica di recupero
del patrimonio edilizio esistente attraverso l’ agevolazione procedurale degli
interventi, circoscrivendo l’obbligo di piano di recupero al centro storico
medievale che viene, per la prima volta, perimetrato come “Zona per
insediamenti storico-ambientali BA” e agli interventi di “ristrutturazione
urbanistica”;
- la
previsone, in una congiuntura di complessiva stagnazione della crescita
industriale, di un parco di aree di circa 75 ettari per attività
“port-oriented”, polarizzate sull’attività produttiva del porto, con il
completamento del relativo sistema infrastrutturale e della relativa
accessibilità (Bretella per il porto, nodo del raccordo autostradale
Pianazze-Stagnoni-Valdilocchi);
-
l’individuazione, in un quadro di livello territoriale, del ruolo strategico
della dismessa Area IP nel contesto
della trasformazione urbana e della formazione di nuove centralità urbane;
- la
previsione di un sistema terziario direzionale, che conferma, con una drastico
ridimensionamento dal punto di vista quantitativo, l’ipotesi localizzativa del
piano del ’58, nella “zona di
saldamento tra la parte storica della città, l’espansione piu’ recente della
piana di Migliarina, e la zona portuale-industriale (zona del Canaletto)”;
- la disciplina
di salvaguardia della zona extraurbana collinare, con destinazioni d’uso
univocamente connesse all’agricoltura o agli usi naturalistici, questi ultimi
articolati in parchi attrezzati e naturali in linea con le innovazioni della
L.R. 40/77. In particolare, il piano destina a parco il 19,4% della superficie
comunale, individuando alcuni sistemi attrezzati sul crinale di Biassa e
Campiglia, sul Monte Parodi, nel sistema Foce-Val Durasca-Sarbia-Mura urbane,
sulle fortificazioni collinari di Monte Albano e di Pagliari;
-
l’individuazione di una sistema viabilistico che ripropone, in misura
semplificata e ridotta, la direttrice di cornice dell’asse attrezzato
ipotizzato dal piano del ’58, privilegiando una riconnessione dei per-