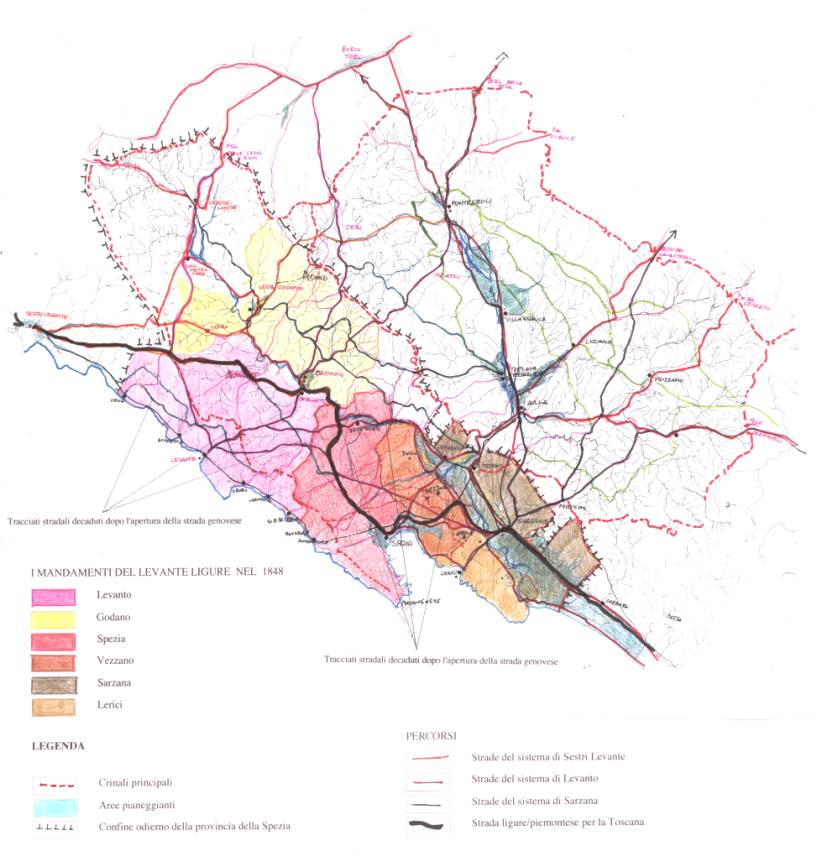1.3. Il sistema dei centri e
delle polarità
Lo
sviluppo tracciato nel paragrafo precedente è quello della formazione dei poli
territoriali di valle o di costa che porta con sè un ulteriore scatto verso la
conquista delle aree pianeggianti dove si formano dei centri specializzati, con
mansione di mercato, destinati a diventare città.
Nel 1343
Simone Boccanegra, doge di Genova, sancisce la costituzione della nuova
Podesteria staccando, da quella più antica di Carpena, le uni-versità di
Spezia, Vesigna, Isola, Follo, Tivegna, Valeriano, Bastremoli. Nel 1371, nella
chiesa di Santa Maria, i sindaci delle podesterie di Carpena e della Spezia
ratificano l'unione delle due giurisdizioni sotto un unico Po-destà che avrà la
sua sede alla Spezia. La città diventò, in questo modo, ca-poluogo di un
territorio ben radicato nelle colline. Tale estensione rimase, sia pure con
variazioni di confine, fino al secolo XIX. Esso rappresentava la pertinenza
della città, il suo "contado". Alla Spezia, per la sua collocazione
territoriale, fu riconosciuto anche un ruolo comprensoriale, quando vi fu
istituita la dogana del sale bianco (1371) e, sempre nel secolo XVI, quando
divenne sede di Capitanato.
Il taglio
diagonale dell'antica strada che collega la bassa val di Magra e Sarzana con
Sestri Levante, ripercorrendo in parte la dorsale del monte di San Nicola
attraverso il passo del Bracco, divide in due settori il territorio della val
di Vara. La parte sud-occidentale comprende la costa da Sestri Levante a
Portovenere, la mezzacosta destra della Vara per Carrodano e Riccò, la dorsale
che separa la bassa val di Magra dal Golfo e il nucleo spezzino. In esso si
collocano centri che hanno svolto un ruolo notevole nel contesto territoriale
della Liguria di levante: primo fra tutti Levanto che formava il confine
settentrionale del territorio spezzino; quindi Vezzano ad oriente che
comprenderà, nel mandamento del 1848, anche Follo e Tivegna, già appartenute
alla podesteria di Spezia. A sud-est, infine, il territorio della città era
delimitato dalle pertinenze di Lerici e Portovenere.
Il ruolo
del nodo spezzino traspare nelle controversie viarie del secolo XVII, quando la
Repubblica di Genova impianta l'asse viario che collega l'antica strada del
Bracco, un tratto della strada che, per Spezia, Riccò e Pignone conduceva a
Genova. I due sistemi viari avevano finalità diverse: il primo collegava
direttamente Sestri Levante con Sarzana senza passare per Spezia, utilizzato
dai postieri lombardi che in quel modo raggiungevano più direttamente la bassa
valle della Magra e la Toscana; il secondo (anch'esso strada di posta),
rappresentava lo spostamento verso levante di un'antica viabilità costiera.
L'intervento della Repubblica di Genova si prefiggeva di creare un'alternativa,
tutta ligure, alla strada principale del Levante, ancorandola alla città della
Spezia e lasciando cadere sia il tracciato costiero che quello interno,
collegante Padivarma con Sarzana attraverso Ceparana, Albiano e Santo Stefano.
Questo tracciato, ripreso ed ammodernato dai francesi e piemontesi divenne la
strada principale da Genova per la Toscana e rimase tale fino al secondo
dopoguerra, quando venne costruito il ponte di Padivarma ed il collegamento con
Piano di Madrignano, ripristinando l'antica direttrice Sestri-Brugnato-Sarzana.
|
TAV. C.5 – SISTEMA DEI CENTRI E DELLE POLARITA’ |
|
|